Perché Filloy
13 12 2024
Perché Filloy
di Giulia Di Filippo
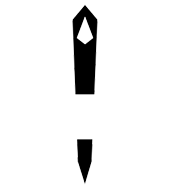
“Pubblicò Aquende nel 1935, mentre Op Oloop è del ’34. Soffermiamoci su quest’ultimo. Lei dice sempre che tutti i suoi personaggi sono inventati, ma sia sincero don Juan: Optimus Oloop è lei, non è vero?”.
Scoppia a ridere.
“Certo, per l’ottanta percento Op Oloop è Juan Filloy”.[1]
Per diverso tempo, un amico argentino mi ha ripetuto in maniera costante: “Che, Filloy”[2]. Mentre con la stessa insistenza nominale e anacolutica un altro argentino, Julio Cortázar, in Rayuela scriveva: «Naturalmente la Maga non poteva saperlo, innanzi tutto perché ignorava la sua esistenza. Dovette spiegarle perché Filloy, perché Caterva».
Una domanda – perché Filloy? – a cui è difficile dare una risposta chiara. Si tratta più di un sospetto, una sensazione fisica, a pelle. Quando ci proviamo un abito, soli nell’intimità di un camerino, come prima cosa non notiamo il dettaglio, la spallina, il fiocco, il bottone, ma il colpo d’occhio, la sensazione di adeguatezza e comodità che ci restituisce l’immagine riflessa nello specchio. Con Filloy credo sia andata più o meno allo stesso modo. Quando ho saputo di Ago, mi è tornato in mente quel mio amico argentino, e poi Filloy. E mi è sembrato che l’unicità del “paroliere di Río Cuarto[3]”, potesse essere un abito perfetto per Ago.
Dunque, perché.
La storia editoriale di Op Oloop ha inizio nel 1934, quando il romanzo venne pubblicato per la prima volta in un’edizione privata con il marchio Ferrari Hermanos. Filloy era solito ricorrere a questa soluzione perché non amava il grande pubblico né era avvezzo alla frequentazione di redazioni e uffici stampa. Si collocò infatti sempre in una posizione marginale, a una certa distanza dai circoli letterari dell’epoca, proponendo i suoi libri solo a pochi ma buoni lettori che conosceva di persona. Come lui stesso raccontò in un’intervista a Monica Ambort, ricercatrice e docente universitaria argentina, Filloy mandò una copia di Op Oloop perfino a Sigmund Freud. Nelle vesti di pubblico ministero, aveva acquisito una certa familiarità in materia psichiatrica e conosceva bene le sue opere: era convinto dunque che l’argomento potesse interessargli. Dopo tre o quattro mesi, lo psichiatra gli rispose con una breve lettera che lo fece gongolare di gioia. Nella stessa intervista confessò: «Non mi interessano queste cose. Per quanto mi riguarda, una volta pubblicato il libro, tanti cari saluti. È per questo che non leggo mai i miei libri. A me interessa solo il libro che sto scrivendo». Successivamente, quando provò a realizzare un’edizione pubblica di Op Oloop, rivolgendosi a Imprenta López, casa editrice che in quel periodo stampava la rivista «Sur», venne minacciato di confisca dall’intendente di Buenos Aires, Mariano de Vedia y Mitre, che Filloy anni più tardi avrebbe definito “gazmoño”, ovvero “bigotto”. Il libro uscì poi con la casa editrice Paidós, insieme a ¡Estafen! e La Potra, nel 1967.
Come poi sarebbe successo ad altri suoi romanzi – come Vil y vil – la prima edizione del romanzo venne censurata con l’accusa di pornografia, a causa delle descrizioni erotiche e dei tratti grotteschi di alcuni personaggi, che trasgredivano la morale argentina dell’epoca. Il caso vuole però che oggi Op Oloop sia il romanzo più tradotto dell’intera opera di Filloy – i cui titoli, non a caso, sono tutti formati da sette lettere – seguito da Caterva. La prima traduzione fu quella in francese, sempre per un’edizione privata; poi seguirono gradualmente le altre lingue: tedesco, inglese, ceco, portoghese, russo, turco, e ora anche italiano. Infatti, benché i suoi libri non siano mai diventati dei veri e propri best sellers, come è successo per altri scrittori sudamericani che per diversi motivi passarono in secondo piano rispetto a una rosa ristretta di scrittori di punta, soprattutto sul piano internazionale, negli anni sta crescendo un nuovo interesse per l’opera di Juan Filloy, con una grande attenzione da parte della critica e dei lettori.
Poi, ovviamente: la lingua. Op Oloop è un romanzo dalla trama esigua, dove a dominare è la lingua. Filloy, che nella vita era stato molte cose, dall’arbitro di boxe allo scrittore, dal nuotatore al pubblico ministero, fino a diventare maestro di palindromi – tanto da scrivere un trattato sulla palindromia, Karcino – usa una lingua altrettanto poliedrica, allo stesso tempo altisonante e volgare, in cui mescola termini specialistici ed espressioni dal sapore antico – vesania, ataraxia, aciago, grato, eiroineia – a termini informali, osceni, o appartenenti al vecchio gergo dei migranti italiani di Buenos Aires, il lunfardo – carajo, cafishear, tongo, franela, cafiolo, mierda, pene, vaginal. Oppure, ancora, a parole inventate di sana pianta – abelardizar, periscopear, medular, esclareamiento. Nonostante questi presupposti apparentemente confusionari, Filloy riesce a creare, tassello dopo tassello, un pastiche linguistico – che rammenta a tratti uno stile gaddiano – eterogeneo ma perfettamente funzionante:
«In fondo, cafishear i cavalli o le donne non fa differenza!…».
«Cafishear? Di cosa parli, Robín?» si apprestò a chiedere Ivar Kittilä, desideroso di non perdere il filo del discorso.
«Be’, è lunfardo, no?: cafishear, sfruttare, essere un cafisho».
«Certo» intervenne Op Oloop. «Ma il termine cafisho nasce da una storpiatura del dialetto cocoliche del termine stockfish. Forse era l’un insulto di qualche magazziniere italiano…».
«Ma sì, ha ragione! E chissà che la parola franela non sia nata dall’insulto di una “francese” a un cliente flaneur. È strano il lunfardo. Magari la parola cafiolo, che del resto è sinonimo di cafisho, ha un’etimologia simile. Non verrà mica da una contrazione dispregiativa di café au lait, bevanda prediletta dei frequentatori dei postriboli?». (p. 224-225)
I giochi di parole, i riferimenti ad altre opere letterarie o artistiche, i termini in altre lingue, gli scarti di registro, i neologismi: nessuno di questi elementi è trascurabile, ognuno rappresenta un punto di raccordo di questo grande tessuto narrativo:
«Oh, no, cherie! Non riusciranno mai ad abelardizzarci. La nostra unione è invincibile. Trascende ogni volgarità. Se la situazione dovesse complicarsi, riusciremo a salvarci grazie alla nostra fiducia reciproca. Non sono come Abelardo. Nessuno riuscirà ad abelardizzarmi! Non riusciranno mai ad abelardizzarci!».
Mentre ripeteva la frase con un furore crescente, il medico e gli accompagnatori si avvicinarono a lui. […] Il medico – un giovane appena laureato, che sfruttava a suo favore il titolo, il nome e lo studio del padre – si fece la stessa domanda. E, ignorandone il significato, sentenziò a bassa voce, rivolgendosi agli altri: «È un neologismo. Brutto sintomo! Esistono diversi tipi di psicosi con tendenza al neologismo». (p. 60)
E la punteggiatura, una personalissima punteggiatura, è il filo che tiene insieme questi pezzi di stoffa. Le frasi, squisitamente involute, sono costellate di trattini, puntini di sospensione, due punti, punti e virgola che orchestrano il respiro dei personaggi, e del lettore. Aspetti complessi da affrontare in traduzione, dove ho sempre cercato di rendere in italiano l’originalità del romanzo, senza però rischiare di compromettere la fruibilità del testo. Ho perciò scelto di mantenere i termini in lingua e i giochi di parole dove necessario, poiché il testo originale era già carico di termini in corsivo provenienti principalmente da francese, inglese, italiano, latino e greco antico: potiche, side-car, hall, chez elle, chauffeur, valet, aperire, my darling, bijouterie, self-control, jockeys, grimace, crèpe, eccetera.
Una lingua precisa e meticolosa quanto la vita di Op Oloop, scandita e dominata dalle più esatte regole matematiche. Ma, come il battito di ali di una farfalla, l’incidente stradale in cui resta coinvolto all’inizio del racconto, un banale contrattempo, è sufficiente a scardinare il suo ordine interiore. La tensione verso l’inevitabile è ordita come la tela di un ragno, pagina dopo pagina, rintocco dopo rintocco, ora dopo ora, minuto dopo minuto. Il romanzo è infatti strutturato come un’Odissea della durata di poco più di 20 ore, in cui in realtà a essere protagonista è il tempo. I capitoli disomogenei in cui si divide il romanzo scandiscono il tempo che passa: dalle 10:00 del mattino fino alla fatidica ora della morte dello Statistico: le 5:49 del 23 aprile 1934.
Oltre la lingua, dunque, un’unica regola: infrangere tutte le altre.
Op Oloop si era convinto ancora una volta che non è possibile tradire sé stessi. domenica: scrivere dalle sette alle dieci, era la regola. Quando la vita è ordinata come un’equazione, non è possibile infrangerne le leggi matematiche. Era incapace di concedersi il minimo improptu al di fuori delle norme prestabilite; perfino l’impercettibile impromptu grafico di scrivere un nome e un indirizzo su una busta di carta. (p. 6)
Non è un caso, visto che per Filloy la regola della scrittura si imponeva come un imperativo categorico:
«Ed è rimasto fedele alla sua intenzione di non smettere mai di scrivere, neanche un solo giorno?».
«Ah… certo… basta un solo rigo, ma non c’è giorno in cui non scriva. Scrivere è per me un vice impuni». (Ambort, 2000)
A partire da queste premesse e da questa struttura prevedibile ma sorprendente, Filloy costruisce un’opera dalla forte impronta esistenzialista, che si pone in netto contrasto con la corrente realista che aveva invece caratterizzato la letteratura argentina ed europea fino a quel momento. In un’intervista pubblicata sulla rivista «Puro cuento» nel 1987 spiegò:
Io mi sentivo uno scrittore, semplicemente. Non tolleravo nulla di ordinario, pacchiano, volgare o mediocre. E nel ’30, quando iniziai a pubblicare, alcune delle persone che lessero Op Oloop e Aquende dissero: “Bene, ci troviamo davanti a un riformatore della letteratura argentina, un uomo che non ricorre agli eufemismi”. Lo dicevano davvero. Il punto è che, all’epoca, tutta la letteratura argentina era eufemistica. Si diceva “vada a defecare”, mentre io iniziai a scrivere “la finisca con queste stronzate e vada a cacare”. È molto diverso. La poesia con eufemismi, per esempio, snatura il personaggio.[4]
Per superare le tradizionali forme realistiche, l’autore si serve anche di un altro strumento: la parodia. In occasione della stessa intervista, parlando della sua predilezione per il romanzo, piuttosto che per le forme brevi, ammise: “Certo, amo la burla. Così come allungare le descrizioni, poetare un po’. Il racconto è un genere asettico; è una linea retta”. In questo contesto, metafore e similitudini diventano i ferri del mestiere attraverso cui Filloy manipola la realtà, dirigendosi verso i lidi immaginifici della fantasia. In maniera analoga ad alcuni suoi connazionali – tra cui l’Oliverio Girondo di Veinte poemas e Calcomanías – crea immagini fortemente surreali e surrealiste, che spesso vedono gli oggetti animarsi:
Ma non riuscì a scrivere altro se non la S di Signore. Una S maiuscola sottile ed elegante a forma di gancio di macelleria. E ci appese la carne: la sua stanchezza, e l’anima: il suo fastidio. (p. 5-6)
Per l’intero romanzo, Op Oloop attraversa stati di veglia e delirio, di acume e pazzia, che finiscono per cristallizzarsi in una perenne lucidità allucinata. Alla fine, tra sogni senza fine e paesaggi onirici, desideri inconfessabili e visioni oscene, il memorabile personaggio di Filloy, “una delle creature più formidabili della letteratura argentina del xx secolo” secondo Mempo Giardinelli, non riesce a sostenere il peso dell’elemento più puro che c’è: l’amore, e quindi della vita: ovvero di ogni sentimento che non soggiace al metodo.
In definitiva: perché? Perché oltre l’apparente follia, al di là della scorza di una lingua volutamente esatta e disciplinatamente complessa, Op Oloop è un romanzo senza tempo, un romanzo d’amore sui generis che ci ricorda ancora, a novant’anni dalla sua prima pubblicazione, il nostro umano e fragile attaccamento alla vita.
«Non protestare, Franzi. In fin dei conti muoio di amore». (p. 355)
[1] Da un’intervista contenuta in Ambort M. (2000), “Sobre su obra. Optimus Filloy, Marechal y el Dr. Freud” in Juan Filloy. El escritor escondido, Aguilar, Buenos Aires.
[2] Che è un tipico intercalare argentino usato per chiedere o domandare qualcosa a qualcuno, o per richiamare l’attenzione.
[3] Definizione di Fabrizio Gabrielli in Il paroliere di Rio Quarto, “Il Tascabile”, 9 febbraio 2017, disponibile al link https://www.iltascabile.com/linguaggi/juan-filloy/
[4] Disponibile al link: https://www.autoresdeconcordia.com.ar/autores/179/perfil.

